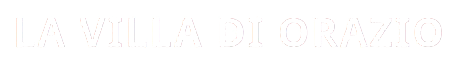Il panorama edilizio dell’Impero Romano, soprattutto da Nerone in poi, fu caratterizzato anche da costruzioni fatte di mattoni: materiale facile e veloce sia da realizzare sia da mettere in opera e bello esteticamente, anche se spesso “nascosto” dietro il rivestimento di intonaco o in lastre marmoree.
In età più antica, almeno fino ad Augusto, prevalse l’uso di mattoni crudi (i lateres, secondo la terminologia di Vitruvio, da cui opus latericium), dei quali nulla è rimasto, mentre numerosi sono i resti di costruzioni realizzate in mattoni cotti (tegulae, lateres cocti e testae, da cui opus testaceum). Anche questo era un materiale versatile, perché poteva essere impiegato, ad esempio, come rivestimento di strutture in opus caementicium (ricorrendo dapprima a corsi di tegole smarginate e in seguito a mattoni veri e propri) o nelle suspensurae, i tipici pilastrini che sostenevano il pavimento dei calidaria (le vasche di acqua calda) delle terme.
Le dimensioni dei laterizi erano modulate sui multipli e sottomultipli del piede romano corrispondente a cm 29,60. La forma, quadrata, rettangolare, triangolare e persino circolare, veniva predisposta prima della cottura usando arnesi da taglio o seghe. In tal modo si ottenevano mattoni adatti alle diverse esigenze architettoniche. In molti casi veniva sfruttata la differenza cromatica generata dalle diverse temperature di cottura o dal tipo di argilla, per creare motivi decorativi, evitando così il ricorso a materiali diversi.